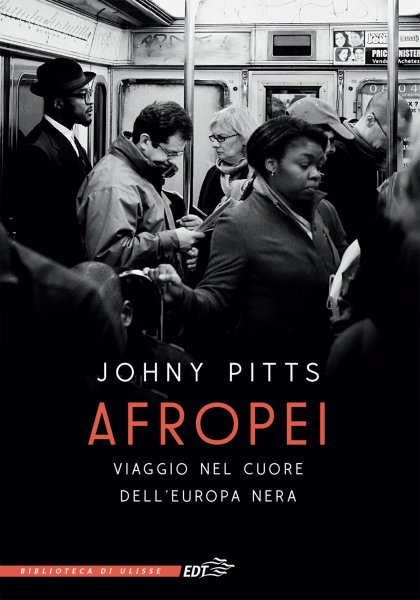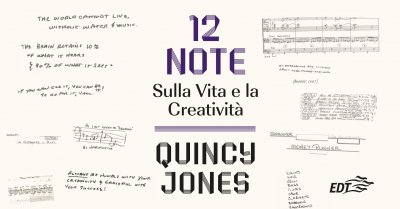Afropei, un viaggio tra le culture

Uscito in Inghilterra all’inizio di giugno, Afropei è un libro rivelazione che ha provocato un acceso dibattito sui media di tutta Europa.
Johny Pitts, l’autore, è un giovane artista e scrittore nato a Sheffield, nell’Inghilterra del Nord, da padre afroamericano di Brooklin e madre bianca inglese. Come molti altri neri delle seconde o terze generazioni europee, Pitts non accetta di dover scegliere fra l’appartenenza alla “comunità nera” e quella alla cultura europea: si sente europeo e nero. Comincia così un’indagine sulla propria identità, e su quella realtà che, usando un termine coniato da David Byrne dei Talking Heads, è il mondo degli afropei, gli europei di origine africana. Quello afropeo è il continente sommerso dell’Europa contemporanea: è una realtà da 30 milioni di persone, circa il 10% dell’intera popolazione, alla ricerca della propria identità, così come nel secolo scorso il mondo afroamericano. Una realtà composita e vastissima, una moltitudine che reclama il diritto di non sentirsi straniera nella propria patria. Pitts decide di partire in un viaggio di conoscenza di questo mondo “nascosto sotto gli occhi di tutti”, e attraversa l’intera Europa, in cinque mesi di viaggio a proprie spese e a bassissimo budget; visita così molte delle principali capitali: Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Berlino, Stoccolma, Mosca, Marsiglia e Lisbona. In ciascuna di queste città entra in contatto con la comunità nera e con i nuovi ghetti, ne osserva le caratteristiche, ne descrive l’esclusione, ne tratteggia le abitudini e l’umanità; ascolta, discute, fotografa, scrive, stringe amicizie. Afropei è il risultato di questa nuova Odissea: un libro brillante e umanissimo, destinato a fare discutere per la sua straordinaria capacità di scardinare alla base l’equazione “nero uguale straniero” che da anni inquina il dibattito politico e culturale del nostro continente.
“Madre bianca inglese, padre afroamericano, Pitts va alla ricerca della propria identità e di quella di gente come lui, partendo dalla questione di fondo, che è la questione del momento. Si può essere neri in Europa senza essere immigrati sbarcati dai barconi? Un viaggio on the road lungo cinque mesi, che lo ha portato agli estremi dell’Europa.” La Stampa
“La storia di Pitts assume le dimensioni di una saga epica. Alla fine del libro non siamo sicuri che lui abbia trovato la sua identità. Ciò che è chiaro è che Afropei annuncia l’arrivo di un autore appassionato, in grado di esplorare abilmente e rendere visibile un mondo nero che per molti sarebbe rimasto altrimenti invisibile.” The Guardian
Johny Pitts è uno scrittore, fotografo, musicista e giornalista radiofonico inglese che ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro di esplorazione e documentazione dell’identità africanoeuropea. Sue fotografie sono state esposte in molte città d’Europa e pubblicate in prestigiosi periodici. Ha fondato e dirige il giornale online Afropean.com, parte del Guardian Newspaper’s Africa Network dedicato alla diaspora afropea.
La prima volta che l’ho sentito, mi ha incoraggiato a vedermi come un’entità integra e senza trattini: afropeo. Ecco uno spazio in cui la tradizione nera contribuiva a dare forma all’identità europea. Indicava la possibilità di vivere in, e con, due concetti diversi: l’Africa e l’Europa, o per estensione il Sud del mondo e l’Occidente, senza sentirsi misti, mezzo questo e mezzo quello, afro e qualcos’altro; diceva che essere nero in Europa non significava per forza essere un immigrato.
Le etichette sono inevitabilmente problematiche, e spesso provocatorie, ma quantomeno danno visibilità ai fenomeni. Dal mio limitato punto di osservazione (sono cresciuto in un quartiere operaio di Sheffield, pressato dalle forze esterne del liberismo e devastato da quelle interne, protettive, della grettezza e della guerra fra bande) ho cominciato a notare un mondo prima invisibile per me, o quantomeno poco plausibile. Nel mio angoletto di Inghilterra mi credevo costretto a reagire contro una cultura, oppure a identificarmi eccessivamente con l’altra.
Coniato nei primi anni Novanta da David Byrne e dalla cantante belga-congolese Marie Daulne, leader del gruppo musicale delle Zap Mama, il concetto di “afropeo” mi è arrivato dai campi della musica e della moda. Fra gli altri, lo incarnavano Les Nubians, il duo soul composto dalle sorelle Hélène e Célia Faussart diviso tra Ciad e Francia, Neneh Cherry, cantante e rapper con radici in Svezia e in Sierra Leone, Joy Denalane, che combinava Sudafrica e Germania, nonché la rivista di Claude Grunitzky, «Trace». “Idee e stili transculturali” era il motto della pubblicazione, che rispecchiava l’identità afropea dello stesso Grunitzky, che aveva un nonno polacco da parte materna, era nato in Togo, cresciuto a Parigi e aveva lanciato il suo periodico a Londra. Era una scena affascinante: europei neri affermati, attraenti e talentuosi che senza sforzo articolavano le loro influenze culturali in opere coerenti e creative. Mi affascinava in particolare la sensazione che quell’affermazione di nerezza in Europa fosse lì per restare. Inoltre la sentivo più vicina dell’arrogante linguaggio culturale e politico che arrivava dall’America e più allargata e sfaccettata di quel che proponeva la cerchia dei britannici neri, la cui identità appariva datata e spesso confezionata unicamente intorno alla “generazione Windrush” [quella degli afrocaraibici immigrati negli anni Cinquanta, N.d.T.].
All’inizio, quindi, l’idea di afropeo rappresentava per me un’utopica alternativa al pessimismo che aveva circondato l’immagine dei neri in Europa negli ultimi anni, era un’ottimistica via per il futuro. Volevo quindi creare un progetto che collegasse e presentasse gli afroeuropei come i protagonisti delle loro vite e, con in mente un glorioso immaginario afropeo, ipotizzai un elegante libro fotografico, con una serie di attraenti ritratti accompagnati da brevi testi buonisti. Avrei documentato le storie di successo dell’Europa nera: giovani donne e uomini il cui stile trasmetteva elegantemente e senza sforzo un umore europeo, nero ed emancipato.
Fu una visita alla “Giungla” di Calais, nel 2016, che mi spinse a rivedere quell’impostazione. Di fronte a un aromatico tè al latte, Hishem, un giovane sudanese che viveva lì da dieci mesi e che gestiva uno dei tanti caffè incredibilmente organizzati del campo, mi raccontò di aver perso tutto. Non aveva più nessun familiare in vita, gli restavano solo i ricordi dolorosi del passato e una visione incerta del futuro, ed era incastrato in quel limbo fra Africa ed Europa, fra una casa (di cui aveva miracolosamente ricostruito una parvenza nel suo locale pieno di cuscini) e l’anonimato. Mentre uscivo dalla sua baracca di compensato scricchiolante, mi suggerì di scrivere un articolo sulla sua storia e sulla vita nella “Giungla”, una richiesta che accolsi con disagio. Hishem era intelligente, istruito e capace di argomentare un discorso: perché non lo scriveva egli stesso? Potevo aiutarlo a divulgarlo, e pubblicarlo sul mio sito web, ma che ne sapevo io di come ci si sente a veder massacrare i propri cari, scappare dalla guerra, nascondersi in un container o attraversare il Mediterraneo su un barcone inadatto alla navigazione, solo per arrivare, senza un soldo in tasca, in una baraccopoli gelida e sferzata dal vento in una periferia del nord della Francia, a parte quel che mi aveva appena raccontato lui?
Ci scambiammo i contatti e ripartii a bordo della mia bicicletta, ma mentre pedalavo lungo le strade battute dal vento di Calais mi accorsi di essere seguito dalla Gendarmerie. Attraversai i cancelli bianchi del porto per prendere il traghetto per il Regno Unito, ma fui fermato prima ancora di raggiungere la dogana. Venni perquisito e interrogato: dov’erano i miei documenti? Dove andavo, da dove venivo, quanto ero stato via e perché? Alla fine, dopo altre domande e tante occhiate sospettose, mi fu permesso di accedere a quell’edificio su cui convergevano gli sguardi bramosi di alcuni miei coetanei raggruppati a distanza e con la pelle altrettanto scura. Io ero dentro; loro restavano fuori.