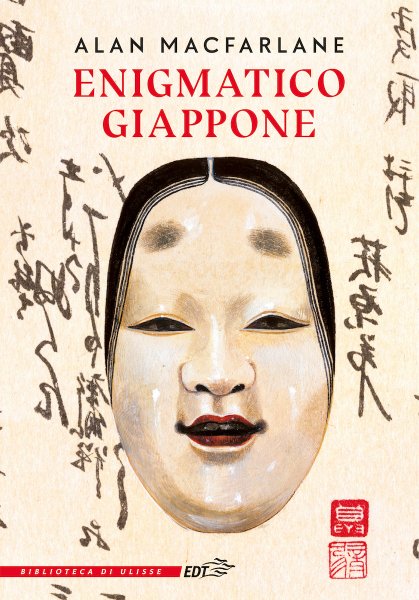Enigmatico Giappone. L’individuo è nei legami
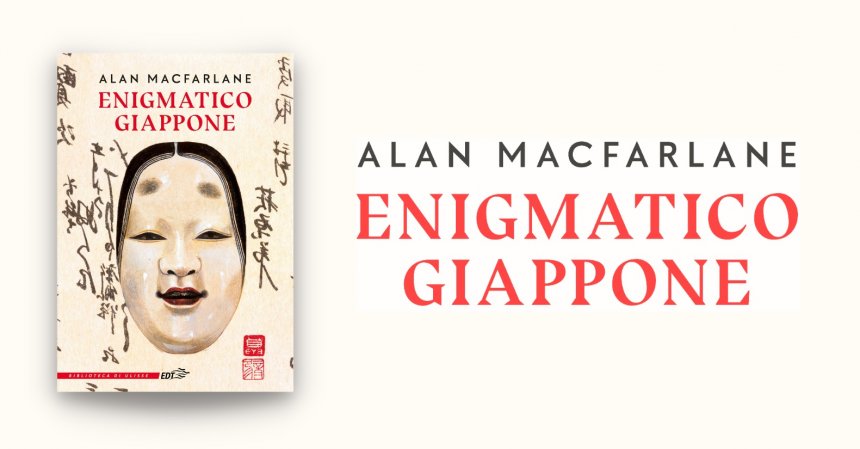
Alan Macfarlane, professore di antropologia a Cambridge, scopre il Giappone relativamente tardi: ha 48 anni quando visita per la prima volta questo paese che conosce pochissimo e verso il quale nutre una serie di preconcetti molto radicati in Occidente, positivi come la raffinatezza culturale e negativi come l'inquinamento e il degrado urbano.
È convinto che si tratti di una sorta di Cina in scala ridotta, con lingua, religione, convenzioni e sistemi di potere tutto sommato simili, con qualche divergenza recente come l'istituzione della Repubblica Popolare in Cina di fronte alla solida vocazione capitalista del Giappone. Non pensa minimamente che la realtà del paese possa rifiutarsi di venire incasellata nelle categorie mentali precostituite che lo studioso occidentale ha in serbo per lei. Invece le esperienze vissute sul posto, combinate con lo studio della storia e l’osservazione della cultura locali, gli sveleranno un Giappone molto diverso, difficile da capire non soltanto per gli occidentali, ma anche per gli stessi giapponesi.
Tra i vari aspetti sorprendenti osservati da Macfarlane c’è l’interpretazione giapponese del concetto di individuo. L’inizio del Capitolo IV, intitolato Il popolo giapponese, è di grande interesse alla luce della concezione occidentale postmoderna dell’individuo, in cui il funzionamento prevale sull’esistenza e le singolarità somigliano sempre di più a profili e sempre di meno a soggetti definiti in base a relazioni e legami.
Da un certo punto di vista, si ha l’impressione che in Giappone non esistano singoli individui. L’individualismo di stile occidentale, infatti, non è mai penetrato in profondità. Ricordo quanto mi colpì la forza di questa strana idea quando iniziai a documentarmi sulle concezioni giapponesi dell’Io, prima di incontrare un giapponese in carne e ossa.
Benché la lingua giapponese possieda molte forme equivalenti ai nostri pronomi personali, esse vengono usate di rado. All’età di sei anni, un bambino giapponese deve avere la padronanza di almeno sei termini per riferirsi a se stesso, e una bambina di almeno cinque. Di solito nessuna di queste forme equivale al pronome “io”. È come se l’individuo fosse esterno al suo “io” e si riferisse a se stesso guardando con gli occhi della persona con cui sta parlando. Tale processo di autoidentificazione è così complesso che in una conversazione il problema di chi sia l’“io” e chi l’altro può porsi in modo alquanto ambiguo, poiché l’“io” e il “tu” sono relazionali e si mescolano tra loro.
Un altro esempio della mancanza di qualsiasi concetto definito che indichi un individuo è il modo in cui vengono usati i nomi delle persone. In Occidente abbiamo tutti un solo nome, e, anche se una donna cambia il proprio cognome sposandosi, il nome rimane di norma immutato per tutta la vita. “Io” sono e resterò “Alan” per tutto il corso della mia esistenza. In passato, in Giappone (come in Vietnam e in Thailandia) le persone avevano un nome diverso a seconda delle fasi della loro vita e ne acquisivano uno nuovo perfino al momento della morte. “Quando nasce un bambino” scrisse Charles Thunberg nel XVIII secolo, “riceve dai genitori un certo nome che, qualora si tratti di un maschio, manterrà fino al raggiungimento della maturità. A quel punto il nome cambia. Se in seguito la persona ottiene una qualche carica, il suo nome muta nuovamente; e la cosa si ripete se, nel corso del tempo, si guadagna un avanzamento di carriera”.
Morse cita alcuni esempi dei tanti nomi che un individuo può avere, ciascuno dei quali può essere cambiato: sei (nome del clan di appartenenza); uji (nome della famiglia); tsucho (che equivale al nostro nome di battesimo); go (nome scolastico); azana (altro nome legato alla scuola); imina (nome di uso legale, riportato in contratti, transazioni e così via); e un altro nome ancora dopo la morte. Quando in Occidente scriviamo l’indirizzo di una lettera, vengono prima di tutto il nome (quello di battesimo) e il cognome della persona, seguito dalle indicazioni geografiche, come un cerchio che si allarga: via, città, nazione. In Giappone, fino a tempi recenti, avveniva esattamente il contrario e il nome della persona veniva per ultimo, nella massima discrezione.
Lo storico Yoshihiko Amino ha schematizzato le quattro categorie di nomi che in passato venivano dati in Giappone: quello avuto da bambini, di solito un vezzeggiativo e spesso un diminutivo, come maru per esempio, che indica qualcosa di carino e tondeggiante; il nome usato dagli altri per rivolgersi alla persona, per esempio ichirō, che significa primogenito; il nome vero e proprio, scelto di norma dal padre con estrema cura, che include di solito due caratteri cinesi, uno dei quali richiama il nome del nonno; infine, il nome dell’età adulta, quando la persona può scegliere da sé come chiamarsi, di solito optando per nomi tradizionali e senza grandi pretese.
Oggi la situazione è cambiata; nel corso della vita le persone non mutano più il loro nome così frequentemente. In ogni caso, la mancanza di punti fissi non creerebbe grandi problemi, dato che le persone tendono a rivolgersi le une alle altre chiamandosi non per nome ma utilizzando il termine che definisce la posizione dell’interlocutore dal punto di vista professionale, gerarchico e così via (possono chiamarsi sensei, cioè maestro, oppure presidente, caporeparto, o con un altro termine appropriato). Quando cambiano i rapporti di status, cambia anche il modo in cui le persone si rivolgono l’una all’altra. Nasce da qui l’importanza che in Giappone rivestono i biglietti da visita, non perché vi è riportato il “nome” di una certa persona bensì il suo status e la sua posizione sociale.
Molti hanno notato che in Giappone il “significato” di un individuo non è intrinseco, cioè non è “impresso” nella singola persona come da noi in Occidente. Non esiste alcuna anima o sostanza unica nel suo genere. Il significato di un individuo è nella relazione con un altro. La cosa risulta evidente se pensiamo alla parola che definisce “essere umano”, composta infatti da due caratteri cinesi, di cui uno sta per “umano” (nin) e l’altro significa “tra” (gen). Una delle interpretazioni vuole che l’essere umano rappresenti per definizione un “rapporto”, non un atomo autosufficiente. L’idea stessa di “persona” separata dalle altre e autonoma che è alla base del pensiero e dell’individualismo occidentale è totalmente assente in Giappone.