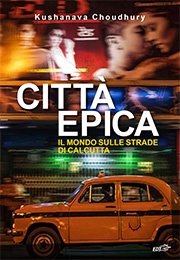Calcutta, Mondo: un estratto da "Città epica"
Da quel momento la nostra vita a Calcutta divenne più semplice. Incominciammo a fare passeggiate per la città. Portavo Durba a College Street, il quartiere delle librerie. Passavamo in rassegna le bancarelle dei libri usati cercando le occasioni e finivamo alla Coffe House, dove le persone andavano non per il caffè, ma per l’adda. Avevo sentito dire che scrittori e rivoluzionari ci si incontravano per parlare di Marx e di Mao, ma in un’epoca precedente alla mia. Era trascorsa almeno una generazione, da quando qualcuno aveva fomentato una rivoluzione mangiando cotolette di pollo. Ma i camerieri continuavano a portare il turbante, i loro modi erano sempre bruschi, la rapidità ancora glaciale e alla Coffe House nessuno ti chiedeva mai di sloggiare. Durba e io bevevamo caffè freddo e parlavamo di politica, come gli amanti di un film di Satyajit Ray arrivati sul set con trent’anni di ritardo. Poi percorrevamo senza meta i vecchi quartieri della parte nord di Calcutta – Badur Bagan, Parsi Bagan, Hedoa, Chalta Bagan – un intrico di stradine intime, le case centenarie con i loro meravigliosi balconi in ferro battuto. Durba non aveva mai visto quei quartieri. Le sembrarono straordinariamente esotici. Percorrendo quei vicoli le tornò in mente il quartiere di Castelo, a Lisbona, che avevamo visitato insieme un anno prima. Le confidai che quando avevamo passeggiato per le strade di Castelo insieme avevo pensato costantemente a Calcutta. Il tintinnio dei tram di Lisbona mi aveva fatto desiderare ardentemente un viaggio in tram lungo College Street. Anni prima, quando ero stato a Cordova, in Spagna, continuai, avevo adorato le croquetas perché assomigliavano moltissimo alle “cotolette” bengalesi. Subito dopo aver scoperto l’eredità altissima di Antoni Gaudí a Barcellona, avevo tracciato paralleli mentali con il suo contemporaneo, Rabindranath Tagore. Ero stato a Polokwane, in Sudafrica, e la vista di un barbiere che lavorava di fronte a una bancarella che vendeva pollo fritto mi aveva fatto tornare a Bowbazar. Nella minuscola St. George’s, a Granada, la cantilena del bigliettaio sull’autobus mi aveva trasportato a Jadavpur e al minibus che, lungo la tortuosa Convent Road, portava all’aeroporto. Mi ero ritrovato all’angolo di una strada di Singapore all’ora di punta e il rumore del suo silenzio mi aveva riempito di orrore. A New York, le zone off-limits del Bronx erano in conflitto con la mia predisposizione, tipica di chi nasce a Calcutta, a prendere tutte le strade che vuole. Trovai sollievo a Chinatown, dove vendono il pesce fresco proprio come al mercato di Maniktala. Camminando insieme a Durba per i vicoli, volevo dare un senso alla città che mi era sfuggita in quanto giornalista, la città che esercitava su di me la sua attrazione magnetica. Volevo percorrere quei vicoli senza correre alle conferenze stampa, senza scadenze. Il viaggio nei suoi vicoli mi portava in un labirinto di stradine sempre più strette. In una città senza indicazioni stradali, l’unico modo per raccontare una storia è seguire i suoi vicoli. Volevo tornare a vivere a Calcutta.
[Kushanava Choudhury, "Città epica"]