Camere oscure: un disco, nove rapper e un paese
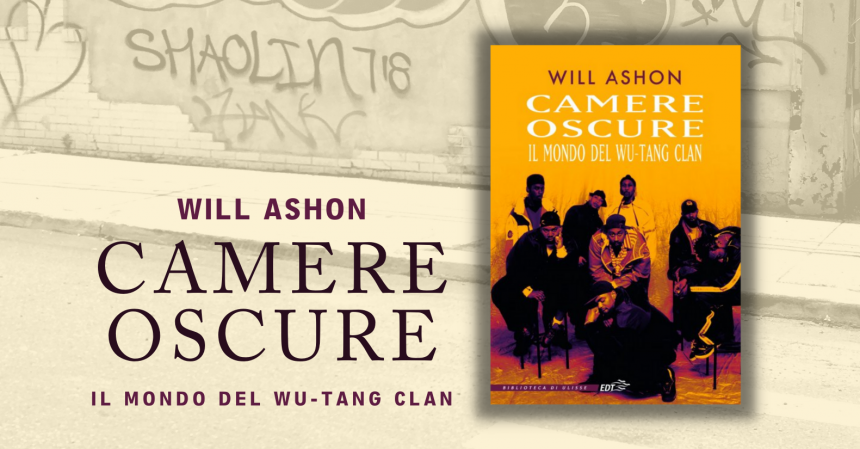
Enter the Wu-Tang (36 Chambers) ha cambiato per sempre la storia dell’hip hop. Il libro di Will Ashon racconta la storia di questo disco e di un’America che, tra segregazione e violenza, riesce in qualche modo a produrre meraviglia.
All’inizio degli anni Novanta il cuore della scena hip-hop americana pulsava in California con il G-Funk di Dr. Dre e del suo The Chronic. La risposta della Costa orientale arrivò nel 1993: Enter the Wu-Tang (36 Chambers), un album che cambiò per sempre l’identità sonora di New York. Il disco non avrebbe potuto essere più lontano dalle tendenze commerciali che dominavano all’epoca: una proposta innovativa che in un baleno trionfò nei negozi di musica e per le strade.
La storia del Wu-Tang Clan era iniziata qualche tempo prima a Staten Island, il quinto dei Boroughs di New York, il meno alla moda e il più periferico. Brooklyn è a est, e a nord-est c’è Manhattan. A partire dall’entrata in funzione del Ponte di Verrazzano, nel 1964, Staten Island era stata presa d’assalto da un gran numero di newyorkesi degli altri distretti: si trattava in buona parte di famiglie bianche in cerca di un alloggio economico e non lontanissimo dal centro. Nella loro scelta influivano anche i violenti disordini a sfondo razziale scoppiati dopo l’uccisione di James Powell, un quindicenne afroamericano di Harlem, da parte della polizia.
Il mito di fondazione del Wu-Tang Clan vuole che il collettivo sia nato quando due fazioni di Staten Island in guerra tra di loro si misero insieme per andare alla conquista di New York e del mondo. La realtà è diversa: questa coalizione tra due gang rivali non c’è stata. Il primo nucleo del Clan, formato dai cugini RZA, GZA e Ol’ Dirty Bastard, veniva da Brooklyn, e questo gli permise di superare la rivalità che in effetti divideva i membri che si sarebbero aggiunti e rese possibile la formazione del gruppo. Al tempo stesso, però, la diversa origine segnava fatalmente un’altra divisione all’interno del Clan, di cui quelli di Staten Island avrebbero potuto risentirsi. È, questa, una costante del libro di Will Ashon: tutte le storie oscillano tra luci e ombre, tesi e rovesciamento, un continuo processo dialettico che coinvolge tutti i temi trattati, dall’hip-hop alla questione razziale, dalla violenza alla repressione, dall’identità alla narrazione.

Wu-Tang Clan live al Budapest Park, 2015
A ranghi completi, il Clan contava nove membri. Otto sono ancora vivi: Ol’ Dirty Bastard è morto di overdose nel novembre 2004. Sette su nove sono stati almeno una volta in carcere. Un dato non sorprendente, non tanto per la loro appartenenza a un ambiente fortemente infiltrato da droga e armi da fuoco, ma per il semplice dato statistico che si tratta di afroamericani cresciuti negli anni Ottanta, quando raggiunse il culmine la strategia repressiva che, sottolinea Ashon, poggiava sull’«uso del crimine come linguaggio sostitutivo per la razza». Questo elemento comune alla biografia di molti dei protagonisti del Clan permette ad Ashon di delineare uno dei tanti ritratti dell’America che stanno sullo sfondo di Enter the Wu-Tang.
L’America produce carcerati. I numeri sono impressionanti. Negli Stati Uniti il rapporto tra i detenuti e il totale degli abitanti è il più alto del mondo industrializzato, superiore a quello della Cina e dell’Iran. A farne le spese sono soprattutto le minoranze etniche, che dalla carcerazione hanno una via segnata verso l’emarginazione. Sul perché il sistema di vita americano tagli fuori un numero così spaventosamente alto di persone e le releghi in carcere sono state formulate moltissime ipotesi, anche perché non si tratta di un fatto nuovo: già nell’Ottocento l'argomento attirava l’attenzione dell’Europa. Alexis de Tocqueville, il grande pensatore liberale, visitò gli Stati Uniti nel 1831 e studiò attentamente il sistema penitenziario americano, considerato all’avanguardia soprattutto rispetto al fallimentare modello francese.
Tocqueville, che pure riteneva che una volta infranto il patto che lo legava alla società il criminale perdesse ogni diritto civile, sviluppò convinzioni molto avanzate per l’epoca, tra cui l’idea che ciascun detenuto dovesse essere libero dallo stigma sociale e potersi ricostruire una vita una volta scontata la pena, anche grazie all’abolizione dell’ergastolo che chiudeva qualsiasi porta al reinserimento e alla speranza. Il principio del reinserimento, osserva Ashon, sembra però trovare difficile applicazione nell’America di oggi.
Per gli ex detenuti, soprattutto se appartenenti a minoranze, il cammino del reinserimento è irto di ostacoli. La fedina penale sporca relega il soggetto in «un circuito chiuso di perpetua marginalità». Gli effetti si fanno sentire in tutti i campi, dalla ricerca di lavoro all’accesso agli alloggi popolari e ai sussidi, fino all’esclusione dall’incarico di giurato e addirittura dal diritto di voto, dal momento che farsi reinserire nel registro elettorale dopo una condanna è molto complicato.
Al concetto di detenzione fa da opposto naturale quello di fuga. La fuga che interessa il Wu-Tang Clan, tuttavia, è molto particolare: si tratta di un’evasione che non riconosce l’autorità pur non avendo niente da spartire con la galassia anarchica. È una fuga da una prigione che racchiude un’intera esistenza, un altro degli affascinanti rovesciamenti operati da Ashon.






