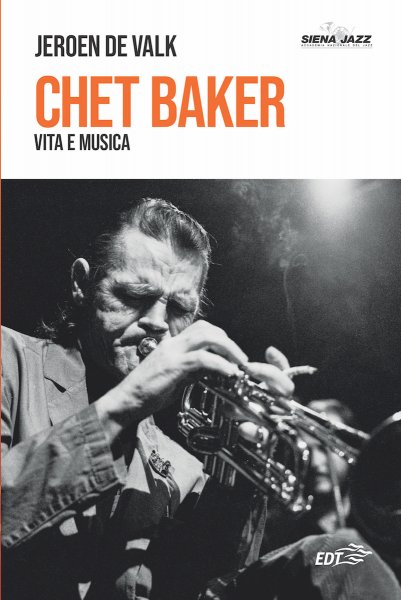Chet Baker, la biografia definitiva

Le vicende del trombettista che a 23 anni era già una star internazionale, vincitore dei referendum delle principali riviste di jazz americane, e sul punto di iniziare persino una carriera cinematografica grazie al suo look alla James Dean, ma la cui vita e traiettoria artistica è stata successivamente oscurata dai problemi con la droga e con la giustizia, al punto da far parlare gli appassionati di jazz più spesso di questi aspetti che del suo incredibile talento.
Quella di de Valk è stata la prima biografia di Baker, pubblicata in olandese un anno dopo la scomparsa di Baker ad Amsterdam nel 1988, e da allora tradotta in diverse lingue. L’edizione che si presenta oggi al pubblico italiano, nell’attenta traduzione di Francesco Martinelli, è la versione completamente riveduta, corretta e ampliata di quel libro pionieristico, da cui si può dire che sia nata tutta la ricerca biografica su Chet Baker.
Dopo aver letto praticamente ogni pagina pubblicata su di lui, ascoltato ogni sua registrazione, edita o inedita, dopo aver conosciuto e intervistato lo stesso Baker, oltre che amici e amiche, mogli, colleghi e collaboratori di tutte le fasi della sua carriera – fino all’ispettore di polizia che ne ha indagato la morte ad Amsterdam – de Valk ha costruito infatti una fotografia minuziosa e densa della sua vita. Il risultato è un libro che fa giustizia delle speculazioni giornalistiche e dei falsi miti. Il Baker di De Valk non è il musicista disperato ritratto in tanti articoli e documentari, ma un incredibile improvvisatore – «compongo ogni volta che suono», diceva con disarmante semplicità – un artista capace di inventare infinite melodie, porgendole all’ascoltatore con un suono unico, morbido e inimitabile fino agli ultimi giorni della sua esistenza.
Il volume si chiude con una guida essenziale a quella vera e propria giungla discografica che sono le incisioni di Chet Baker, fornendo di ciascun disco notizie dettagliate e una meditata riflessione critica.
Jeroen de Valk (Rotterdam, 1958) è un musicista, scrittore e giornalista olandese. Scrive di musica come freelance per diverse testate olandesi fin dal 1979. Fra i numerosi volumi che ha dedicato al jazz, nel 1989 ha pubblicato la prima edizione dell’acclamata biografia di Chet Baker, e nel 1992 la monografia di riferimento sul sassofonista Ben Webster (In a Mellow Tone).
Chet Baker è forse il musicista più frainteso di tutta la storia del jazz. Sfogliando articoli su di lui – su riviste o quotidiani, ad esempio – si legge che Chet era un disperato, che aveva iniziato a fare uso di droghe quando la sua popolarità cominciò a declinare, e quando il suo pianista Dick Twardzik morì. Oppure che era scomparso dalla scena dopo un travolgente successo iniziale, e che fu recuperato dall’oblio dal regista Bruce Weber, cui si deve anche la sua ultima registrazione, la colonna sonora per il documentario Let’s Get Lost. O infine si legge che fu assassinato ad Amsterdam, dove la polizia non indagò a fondo sulla sua morte.
La verità è purtroppo assai meno sensazionale. Chet iniziò ad assumere droghe quando era al culmine della sua fama e quando Twardzik era ancora vivo e vegeto. Negli ultimi dieci anni della sua vita Baker godette di immensa popolarità in Europa, dove incise molti dischi e tenne innumerevoli concerti. E in quel periodo suonava la tromba molto meglio di quanto si senta nel film di Weber. Non è neppure vero che la musica per quel film sia la sua ultima registrazione: in seguito fece una dozzina di album, sia dal vivo che in studio. Uno di essi, Live in Tokyo, è uno dei migliori di tutta la sua carriera. E infine Chet non è stato ucciso. Dopo una attenta indagine la polizia olandese ha concluso che era caduto dalla sua stanza d’hotel dopo aver assunto eroina e cocaina. Sembra un finale abbastanza banale per la storia di un eroe del jazz, ma non ci posso fare niente.
Poi si racconta che Chet avesse perso i denti davanti, un vero disastro per un trombettista, a seguito dell’aggressione di uno spacciatore. In realtà aveva perso un frammento di un dente in una rissa nell’estate del 1966, dopo di che aveva continuato a suonare, e nemmeno male. Mise una protesi qualche anno dopo, ma solo perché aveva i denti rovinati.
Ciò che appare davvero strano in tutte le discussioni su Chet è l’attenzione costante alla sua tossicodipendenza e alla sua morte. Sembra quasi che iniettarsi eroina e cascare dalla finestra siano le cose più importanti che Baker possa aver fatto nella sua vita. Ma assumere droghe non trasforma nessuno in una leggenda. E quanto può essere importante alla fine la sua caduta fatale? Ha messo fine troppo presto alla sua vita. Chet, però, è caduto una volta sola, mentre la sua carriera musicale è durata oltre quarant’anni. (Ma non preoccupatevi, in questo libro si dirà in dettaglio anche della sua morte, ci arriverete leggendolo).
Chet era soprattutto un grande improvvisatore melodico. Sapeva creare su due piedi, sera dopo sera, melodie nuove e fresche praticamente su qualsiasi struttura armonica data. Basta ascoltare tutti i suoi assoli su “My Funny Valentine”, una canzone che ha inciso infinite volte; nessuna versione è uguale a un’altra. E riusciva a suonarla ogni volta con il suo timbro favoloso, morbido e subito riconoscibile, e con un’intensità che a volte arriva a provocare nell’ascoltatore un certo disagio.
Era anche un cantante. Da ragazzo aveva una voce leggera, giovane, vulnerabile, piacevole in superficie ma con un retrogusto di malinconia. In seguito la sua voce diventò più profonda e a volte sembrava stanca, ma Chet continuava a interpretare i testi con grande efficacia, meglio di molti cantanti professionisti. E amava anche usare lo scat; negli ultimi anni le sue frequenti improvvisazioni vocali si avvicinavano sempre di più al suono della sua tromba.
Nella versione più diffusa della sua storia, Chet quando tornò sulle scene all’inizio degli anni Settanta era ormai un musicista finito, a malapena l’ombra di quello che era stato. Ma per chi lo ascoltava sul serio, era un trombettista che sceglieva le sue note in modo impeccabile. Il suo fraseggio era sempre avventuroso e il suo stile intimo e lirico è ancora un perfetto modello per tutti i giovani che vogliono diventare musicisti di jazz. Ed è la perfetta traduzione pratica del modo di dire “meno è meglio”.