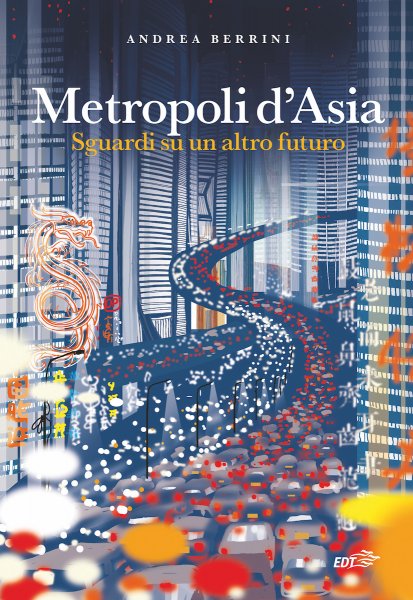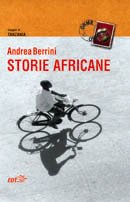Le Metropoli d’Asia, un Altro che ci somiglia

Pechino, la città che cresce ad anello, uno dopo l’altro, fino al settimo la cui circonferenza misura 931 chilometri. Kuala Lumpur con le Petronas Towers, «copie moderniste un po’ art déco di enormi minareti scintillanti di luce, missili puntati contro il cielo di chiunque, campanili da cattedrale gotica». Bombay, lunga, stretta e bellissima, con i quartieri ricchi, le baraccopoli e la contiguità tra i due ambienti a segnare l’anima della città. Hong Kong e la sua lotta per la libertà, grande e tragica, tra la fine del periodo coloniale e l’incorporazione alla Cina. Singapore, in declino come piazza finanziaria, costretta a reinventarsi come meta turistica in cui interpreta sé stessa a beneficio dei visitatori.
Andrea Berrini ha viaggiato e vissuto a lungo in queste metropoli asiatiche e le ha raccontate attraverso gli incontri con artisti, scrittori e intellettuali, ascoltando storie, valutando caratteri, facendosi «ladro di vite altrui, in luoghi dove molto è possibile e molto va raccontato».
Dopo Storia africane, un nuovo viaggio con gli occhi aperti e il cuore attento.
Andrea Berrini, scrittore, editore e imprenditore, è autore di L’anima dei Bulldozer. Viaggio nella nuova baraccopoli africana (Baldini e Castoldi, 1996), Storie africane (EDT 2001, riproposto nella collana Ancore nel 2022) Noi siamo la classe operaia (Baldini Castoldi Dalai, 2004), Il romanzo del microcredito (Baldini Castoldi Dalai, 2008), Scrittori dalle metropoli (Iacobelli, 2017). La sua casa editrice si chiama Metropoli d’Asia e si occupa di narrativa asiatica contemporanea. Ha vissuto a lungo a Pechino, Bombay, Singapore. È il fondatore di CreSud, e si è occupato di microfinanza per venticinque anni.
2014: la rivolta degli ombrelli scoppia nello schermo del mio computer, settembre. Ero a un festival letterario in Indonesia a Ubud, con un lungo programma di incontri, e non potevo muovermi. Avevo una gran voglia di andare a vedere la sorprendente mobilitazione di giovani e non solo, dentro a una piazza finanziaria dipinta come algida e distaccata. Di Hong Kong si citavano le file di persone sempre ordinate e rispettose ovunque necessario, una città dove la parola autorità andava a braccetto con la parola armonia: armonia del corpo sociale, armonia nelle relazioni tra le persone, e armonia dell’individuo con sé stesso e con l’universo, come da tradizione e senso comune orientale, confuciano. In Cina, l’armonia rischia di trasfigurare in oppio dei popoli. Hong Kong pareva ancorata a un’ineluttabile disposizione all’obbedienza.
Il popolo di Hong Kong è porzione minima dell’immenso popolo cinese che negli ultimi trent’anni ha goduto di una crescita economica travolgente, trecento milioni di contadini poveri sono entrati nelle città come lavoratori salariati, e molti di più hanno penetrato l’enclave di una vita migliore, più lunga, meglio nutrita di alimenti e di consumi: il Partito Comunista ha orgogliosamente e un po’ avventatamente proclamato l’eliminazione della povertà. Il popolo cinese è soggetto a una dittatura: regime autoritario, preferisce scrivere qualcuno, ma c’è un’oligarchia ben piantata dentro ai gangli dell’economia di stato, che tutto fa e disfa secondo logiche interne a sé stessa, e senza possibilità di critica dal basso. Oggi Xi Jinping si eleva sul partito come un autocrate a un livello non più raggiunto dai tempi di Mao Tsedong. Azzerata è la libera espressione, quando accade qualcosa, e la protesta a Hong Kong ne è stata un esempio lampante, chi sgarra e riferisce viene arrestato, perfino giornalisti stranieri sono stati espulsi dal paese, i siti scomodi oscurati. Con garbo, magari. Senza le atrocità sguaiate che portano altri regimi sulle prime pagine: qui sanno viaggiare a luci spente, non stuzzicano le opinioni pubbliche lontane, disattente. Le rare voci critiche raccontano la repressione del dissenso utilizzando ironicamente il verbo armonizzare. Se per i cinesi armonia è oppio dei popoli, per le opinioni pubbliche occidentali è cloroformio con caratteristiche cinesi.
Nessuno se l’aspettava: nel 2014 Hong Kong sfida in campo aperto il gigante. Pechino, forte degli accordi siglati da Deng Tsiaoping e da Margaret Thatcher nel 1984, supervisiona la mutazione della colonia britannica in provincia cinese, la sua tardiva e sacrosanta restituzione alla madrepatria. Il passaggio dovrebbe compiersi con gradualità, la data fatale è il 2046, titolo di un noto film di Wong Kar-wai. Nel periodo di interregno, la nuova costituzione prevede l’elezione a suffragio universale del governatore e del parlamento. Gli oligarchi cinesi coniarono la definizione ibrida di “one country, two systems”; per la verità la one country si articola su frontiere ancor oggi piuttosto rigide, con visti di ingresso per la Cina da Hong Kong, e dei due sistemi il secondo, che si prevedeva democratico, a Hong Kong non si è mai realizzato. Alla piena libertà di espressione e manifestazione si affianca ancora nel 2014 una modalità autoritaria di costituzione del potere legislativo ed esecutivo: in parlamento solo una parte dei seggi è elettiva, metà sono nominati dall’alto. La prima elezione a suffragio universale dell’assemblea legislativa e del governatore è prevista per il 2016 e 2017, e qui siamo al fattaccio: Pechino redige una carta di intenti, chiarendo l’intenzione di esercitare un controllo sul processo elettorale, le cui modalità garantiscano un risultato non in contrasto con gli interessi della Repubblica Popolare Cinese. Scoppiano, per le strade, le proteste di quella che passerà alla storia come la rivoluzione degli ombrelli gialli.
Mi piaceva l’idea che una ridotta che conta lo 0,5% della popolazione cinese desse vita a un movimento capace di scuotere il Paese di Mezzo. Certo, la Cina è da anni terra di rivolte, scioperano gli operai nelle fabbriche e nelle miniere, o meglio innescano jacquerie ignorate dall’agenzia di stampa statale, di cui filtrano tracce in rete. Protesta, spesso, chi abita aree con livelli di inquinamento del territorio insostenibili: e di queste proteste si sa di più perché la mediosfera globale è pronta a rilanciarle. Alle rivolte seguono raffiche di arresti. Sul suolo della Repubblica Popolare Cinese una richiesta di democrazia e libertà tanto esplicita non si era mai vista. Perché proprio a Hong Kong? Nell’ancora recente passato coloniale, fino agli anni Novanta, non era contemplata alcuna forma di democrazia rappresentativa, la città non la conosceva. Era però sufficientemente garantita la libertà di espressione: qui sta la risposta. Un’abitudine consolidata a dire, raccontare, leggere, conoscere, muoversi e fare liberamente che per molti individui oggi, per i giovani di sicuro, conta più che non la democrazia in quanto tale, cioè l’esercizio del potere discendente dal suffragio universale.
Hong Kong si svegliava nel momento in cui perfino in Occidente qualche voce, affascinata dalla prorompente crescita cinese, commentava che un regime autoritario ha più agilità di movimento, più capacità di programmazione, più facilità di reazione alle crisi di quanta ne abbia una democrazia. Alla morte dello storico padre padrone di Singapore, un paese che è un po’ il gemello di Hong Kong anche se lontano migliaia di chilometri, commentatori occidentali magnificarono un regime impermeabile al cambiamento e dal pugno di ferro, capace di pianificare crescita economica e di azzerare la corruzione, modello che si vorrebbe esportare perché, ci dicono, mollare qualche cosina dal lato della libertà di espressione e della trasparenza del potere ci renderebbe più ricchi, o meno poveri: più sereni, alfine.
A Hong Kong, da lontano, ero spettatore di un risveglio naïve, come è tipico di una rivolta giovanile, centrato su una richiesta di libertà di espressione tanto disperata quanto ingenua. La domanda di molti ragazzi era: la Cina censurerà la mia pagina Facebook? La domanda che mi facevo io, spero non altrettanto ingenua, era: cos’è la libertà, per voi? Perché è tanto importante? Domanda che sorge là dove la libertà è minacciata: talmente è scontata per noi che nemmeno ricordiamo più di che si tratti, e un minimo livello di costrizione al vaccino pare uno sfregio insopportabile.
Un anno dopo, a movimento già esaurito, decisi di andare a Hong Kong. Cercavo le voci di persone comuni: non i leader. Che me lo spiegassero loro, il movimento degli ombrelli ormai sopito, a distanza, memoria già sedimentata. Non mi interessavano i dirigenti della protesta, personaggi già decostruiti e riassemblati dai media nel solito intento di formulare storie di sicuro impatto. Cercavo gli studenti, i giovani, ma anche gli insegnanti, i professionisti, perfino i venditori di strada e i commercianti che alla rivolta si erano uniti. La metropoli d’Asia come polis del nuovo millennio, dove le persone comuni fanno la politica, non quella degli affari e delle carriere, ma quella del cittadino e delle sue necessità: delle sue voglie. A Hong Kong, ecco, la voglia è di libertà di espressione.