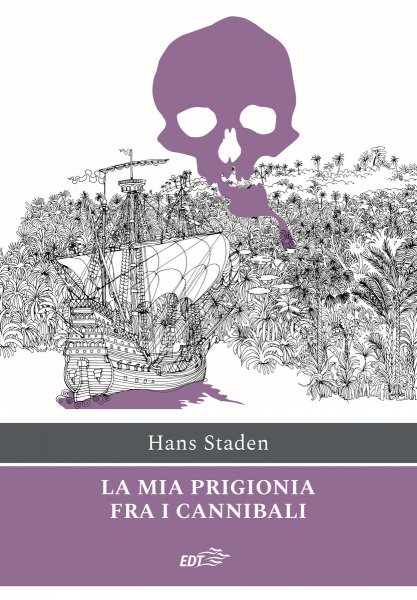Un tedesco tra i tupinamba. La storia di Hans Staden

L’arrivo di Cristoforo Colombo in America ha aperto una fase tra le più sconvolgenti nella storia dell’umanità. È davvero difficile sopravvalutare la portata che la scoperta e l’impatto con l’”altro” rappresentato dagli indigeni hanno avuto sulla civiltà europea, per non parlare del prezzo immane che è costata a quelle americane.
Tra i molti che lasciarono testimonianze scritte di quell’incontro estremo ed esemplare figura Hans Staden, nato intorno al 1525 nell’Assia tedesca. Di lui non si sa quasi nulla al di là delle vicende legate ai due viaggi che intraprese oltremare. Nel corso del secondo, sul finire del 1553, venne catturato dalla tribù di antropofagi dei tupinamba, che viveva in un villaggio nella baia di Mangaritiba, non lontano da Rio de Janeiro. La sua sorte pareva segnata, ma riuscì inaspettatamente a sopravvivere e a rientrare in patria, dove raccontò la propria esperienza in un libro che riscosse da subito uno strepitoso successo. EDT lo ha pubblicato nel 1991, con il titolo La mia prigionia fra i cannibali, e ora lo ripropone nella collana Ancore.
Staden appartiene alla terza generazione di cronisti della conquista. La prima, osserva nell’Introduzione il curatore dell’edizione italiana Amerigo Guadagnini, «si era imbattuta in qualcosa di mai visto e aveva potuto stabilire soltanto un contatto precario con una realtà che sfuggiva agli schemi e ai dogmi tradizionali». La seconda aveva già conoscenze e strumenti per delineare contorni più precisi dell’alterità, la terza «ha ormai la mente aperta a qualsiasi nuova informazione, raccoglie dati precisi, distingue con cura fra una popolazione indigena e l’altra».
Staden rientra in pieno in questo terzo genere di narratore. Senza strumenti e cognizioni, del resto, sarebbe quasi certamente morto poco dopo la cattura. La sua buona conoscenza della lingua tupi, parlata dai suoi catturatori, gli permise invece di farsi ascoltare: gli indigeni odiavano i portoghesi e risparmiarono Staden soprattutto perché questi riuscì a convincerli di essere un tedesco amico dei francesi, con cui i tupinamba avevano invece buoni rapporti.
Proprio il problema della lingua segna una profonda differenza tra le generazioni di cronisti alle quali si è fatto cenno sopra. Cristoforo Colombo non possedeva alcuna sensibilità linguistica, il che lo escluse dalla comunicazione con i nativi, che considerò da subito come non-umani. L’atteggiamento di Hernàn Cortés, conquistatore del Messico e distruttore dell’impero azteco, era già molto diverso: Cortés studiò l’universo indigeno, ne comprese molti aspetti e lo manipolò a proprio vantaggio; attuò dunque perlomeno un tentativo di comunicazione interumana, laddove Colombo era in grado di entrare in contatto soltanto con il mondo inanimato.
Staden è invece un attentissimo osservatore di uomini, delle forme sociali e delle tecniche che gli indigeni applicano alla vita quotidiana. Svolge insomma uno straordinario lavoro da etnografo, che spicca per acutezza e obbiettività. Ne è un esempio il breve estratto che segue, in cui l’autore spiega come gli indigeni producono la bevanda che tracannano fino a ubriacarsi. Oltre al processo di preparazione Staden annota gli aspetti rituali, come le feste che si tengono nei villaggi, le pratiche comunitarie in uso tra gli indigeni e la generosità che caratterizza le loro relazioni.
Sono le donne che fanno le bevande. Esse raccolgono radici di manioca e ne mettono a cuocere grandi pentole piene zeppe. Quando le radici hanno bollito abbastanza, le tirano fuori e le versano in altre pentole o recipienti lasciandole raffreddare un po’. Quindi le ragazze giovani si siedono tutto intorno e si mettono a masticarle, deponendole poi in uno speciale recipiente.
Una volta masticate tutte le radici bollite, le versano nuovamente nelle pentole, che riempiono d’acqua. Mescolano tutto insieme, l’acqua e le radici masticate, e poi mettono a scaldare un’altra volta..
Essi hanno speciali vasi, per metà affondati nella terra, che usano come qui da noi la gente usa i barili per il vino o per la birra. In questi versano il miscuglio, che fermenta da sé e diventa forte. Lo lasciano fermo per due giorni. Poi lo bevono e si ubriacano. È un liquido denso, nutre anche molto.
Ogni capanna prepara le proprie bevande. E quando uno dei villaggi desidera far festa, il che di norma avviene una volta al mese, si radunano tutti insieme in una capanna e bevono fino all’ultimo goccio. Poi passano nella capanna successiva, e così via, fino a consumare la provvista di bevande di tutto il villaggio.
Si siedono intorno ai recipienti da cui attingono, chi sulla legna da ardere, chi per terra. Le donne porgono loro le bevande con ordine e gentilezza. Alcuni stanno in piedi, cantano e danzano intorno ai recipienti. Spandono acqua nel luogo stesso dove sono riuniti a bere.
La bevuta dura tutta la notte. Essi continuano anche a danzare fra i falò, gridano e suonano le trombe, e fanno un chiasso terribile quando sono ubriachi. Ma è raro vederli in discordia. Fra loro sono molto bonari; chi ha più cibo di un altro, lo divide con lui.